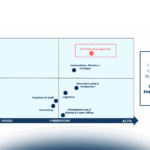È davvero una “crisi” dell’engagement?
Secondo i risultati dell’Osservatorio HR Innovation Practice, più del 60% delle Direzioni HR ha identificato l’aumento dell’engagement dei collaboratori come obiettivo prioritario per il 2023. Nel corso degli ultimi anni, questa sfida ha guadagnato sempre maggiore importanza nelle agende degli HR, soprattutto dopo il periodo post-pandemico. Basti pensare che la percentuale di coloro che considerano l’engagement fondamentale è aumentata di dieci punti percentuali solo nell’ultimo anno. Ma qual è la ragione dietro a questo trend?
Per rispondere a questa domanda partiamo dalla definizione stessa di engagement. Con questo termine si fa riferimento a un legame profondo tra organizzazione e collaboratori, che trascende lo stato di soddisfazione e motivazione contingente. L’engagement rappresenta, dunque, il motore che spinge le persone ad aderire al progetto organizzativo, si fonda sulla condivisione di obiettivi e di valori, genera sicurezza psicologica e fiducia, inducendo comportamenti positivi come impegno, lealtà, propensione alla creatività e al cambiamento. Tutti elementi di cui le organizzazioni hanno bisogno di trovare nelle proprie persone. Tre sono le componenti chiave dell’engagement1: il “Vigor”, ossia l’energia e la forza che si sprigiona quando si lavora, la “Dedication”, l’entusiasmo, l’ispirazione, la dedizione, e l’“Absorption”, ovvero l’immersione completa nel lavoro.
Mantenere livelli alti di tutte e tre le componenti non è oggi impresa facile e sempre più spesso si sente parlare della cosiddetta “crisi dell’engagement”. Effettivamente in Italia, così come a livello internazionale, i lavoratori e le lavoratrici “pienamente ingaggiati” (full-engaged), con livelli alti contemporaneamente su tutte e tre queste dimensioni, sono sempre di meno. Dalle rilevazioni dell’Osservatorio emerge che, dal 2020, dai primissimi mesi di pandemia ad oggi, la percentuale di “full-engaged” si è dimezzata (era il 26%), con conseguenze allarmanti per persone e organizzazioni. Tra gli effetti più noti, c’è il fenomeno del “Quiet Quitting”, letteralmente “l’abbandono silenzioso”, che porta i lavoratori e le lavoratrici a spegnere le proprie energie e a fare il minimo indispensabile al lavoro per non essere licenziati. In Italia si stima che il fenomeno riguardi 2,3 milioni di occupati/e. Da cosa deriva tutto questo? Il “Quiet Quitting” può essere letto come una condizione negativa e patologica del tentativo e del desiderio di alcuni di separare nettamente la propria vita privata da quella lavorativa. È l’approccio del “work-life separation”2 portato all’estremo. L’identikit dei Quiet Quitter descrive persone che hanno perso fiducia nell’organizzazione, che non si sentono prese in considerazione e valorizzate nei propri talenti, sono assolutamente insoddisfatte della condizione lavorativa nel complesso e poco interessate a sviluppare relazioni interpersonali sul lavoro. Attenzione però a non considerare i Quiet Quitter come lavoratori negligenti e sfaccendati, non si tratta di questo. Anzi, la mancanza di motivazione, di fiducia e di relazione pone a rischio il loro benessere psicologico, con conseguenze negative tanto per le organizzazioni quanto per loro stessi. Il fenomeno sorge in risposta al disordine e all’incertezza portata dalla pandemia, dalla ricerca di un nuovo equilibrio tra vita privata e vita lavorativa che spesso non trova risposta nel contesto di riferimento.
È lecito chiedersi, a questo punto, cosa stanno facendo le organizzazioni sul fronte dell’engagement e delle relazioni. Dalla ricerca dell’Osservatorio emerge che circa la metà del campione di Direzioni HR organizza momenti di incontro fisici o virtuali per facilitare la socializzazione – ad esempio cene, apertivi o “caffè virtuali” – e offre ai propri collaboratori esperienze di team building – ad esempio attività ludiche – per rafforzare lo spirito di team e la creazione di relazioni. Si tratta sì di iniziative importanti, soprattutto se calate in un contesto di lavoro ibrido, in cui le occasioni di incontro non sono più quotidiane come in passato, ma da sole insufficienti per creare un nuovo equilibrio sostenibile tra sfera privata e lavorativa. Di contro, il 16% afferma di non aver adottato nessuna azione in particolare per agire su queste tematiche. Oltre alla definizione di pratiche per aumentare e migliorare l’engagement, un’altra attività fondamentale riguarda la sua misurazione. Le azioni in questa direzione sono però sporadiche e poco strutturate: la metà del campione misura l’engagement una volta l’anno o meno, attraverso strumenti di stampo tradizionale (ad esempio le survey di clima), circa il 30% lo monitora in maniera non sistemica, al verificarsi di determinati eventi (come i colloqui per indagare le ragioni di uscita dall’organizzazione), circa il 10% non lo misura affatto.
Il quadro sull’engagement e sulle iniziative volte a migliorarlo non sarebbe completo senza un’altra considerazione rilevante: l’equivalenza “benessere=engagement” non è sempre valida. Se il secondo rappresenta un ingrediente fondamentale per garantire una condizione di lavoro positiva e di valore, non è detto che sia sufficiente. È il caso dei Job Creeper, all’estremo opposto dei Quiet Quitter, lavoratori e lavoratrici (circa 1,1 milione in Italia) più ingaggiati della media, alla ricerca di uno status e responsabilità sempre più crescenti nel lavoro, tesi alla performance e motivati dalle prospettive di carriera, che di contro faticano a «staccare» dal lavoro, rischiando relazioni e comportamenti organizzativi conflittuali o «tossici» e forme di malessere psicofisico (come l’insonnia). Anche in questo secondo caso si tratta di un disequilibrio tra sfera privata e lavoro, che caratterizza coloro che tendono ad assumere un approccio di “work-life integration”3.
Alla luce di questi fenomeni, ha ancora senso parlare di “crisi dell’engagement”? Siamo davvero sicuri che il problema sia – o sia solo – il calo della motivazione e del coinvolgimento delle persone? Forse il rischio è di focalizzare la lente solo su una parte, seppur rilevante, del problema. Quello che l’Osservatorio ha fatto emergere con la sua ricerca è piuttosto una condizione di forte disallineamento tra le aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici e le risposte che le organizzazioni riescono realmente ad offrire. Per concludere, quindi, ciò di cui oggi persone e organizzazioni hanno bisogno è un approccio differente, basato sulla ridefinizione stessa della loro relazione, che sappia varcare i confini della vita privata e quella lavorativa, che punti ad un nuovo equilibrio, all’engagement e alla Felicità.
1“The Utrecht Work Engagement Scale”, Schaufeli & Bakker (2003).
2L’approccio di chi trova soddisfazione personale prevalentemente fuori dal lavoro ed è portato a tenere separata la vita lavorativa da quella privata.
3L’approccio di chi trova nel lavoro una componente significativa della soddisfazione personale ed è portato a gestire in maniera integrata i due aspetti.
A cura di

Chiara Tamma
RicercatriceRicercatrice Junior dell'Osservatorio HR Innovation Practice.
Siamo a tua disposizione per informazioni e assistenza

Martina Vertemati
Acquisti e abbonamenti Da Lunedì al Venerdì, dalle 09 alle 18
Alessia Barone
Assistenza Da Lunedì al Venerdì, dalle 09 alle 18Scopri altri contenuti di HR Innovation Practice